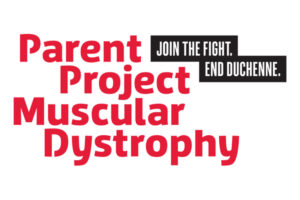Dal 2010 a oggi continua ad aumentare il numero delle condizioni ricercate (con l’Italia al primo posto) e sempre più Paesi hanno introdotto un programma nazionale
Il panorama dello screening neonatale diventa sempre più roseo: in soli dieci anni la maggior parte dei programmi europei è maturata considerevolmente, sia in termini di modernizzazione della metodologia, sia per quanto riguarda l’ampliamento dei pannelli, ovvero il numero delle condizioni indagate. Lo certifica uno studio dell’International Society for Neonatal Screening (ISNS), che ha raccolto i dati relativi all’implementazione del test in 51 Paesi europei, registrando i progressi compiuti nel periodo tra il 2010 e il 2020.
In Europa il record è proprio dell’Italia, che con 49 malattie previste dal panel è anche la seconda a livello mondiale: solo gli Stati Uniti fanno di meglio, con 62 patologie, di cui 35 principali e 27 secondarie.
DIECI ANNI DI PROGRESSI E INNOVAZIONE
Nel contesto di questa indagine, pubblicata nel 2021 sull’International Journal of Neonatal Screening, l’Europa è intesa come un’area geografica costituita da tutti i Paesi situati a est dell’Oceano Atlantico, a nord o nel Mar Mediterraneo e a ovest dei monti Urali. L’ISNS ha deciso di considerare parte dell’Europa anche Israele, la Russia e cinque ex repubbliche sovietiche, posizionate a est degli Urali (Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan). Nel 2019, la popolazione di questi territori era di circa 915 milioni di abitanti, il che significa – con un tasso di natalità medio annuo di 11,9 nati ogni 1.000 persone – un totale di circa 10,9 milioni di neonati.
In Europa, lo screening neonatale è stato introdotto nella parte occidentale del continente durante gli anni ’60, e nel corso dei successivi quattro decenni si è diffuso come un’onda che si propaga da ovest verso est. Oggi praticamente in tutti i Paesi esiste una sorta di screening neonatale istituzionalizzato; alcune nazioni sono così piccole che i test vengono eseguiti in un Paese vicino più grande (il Liechtenstein è coperto dalla Svizzera, Andorra e Monaco dalla Francia, San Marino dall’Italia, il Kosovo in parte dalla Serbia). In Albania, nella maggior parte del Kosovo e nel Tagikistan non esiste ancora un programma ufficiale, ma in Albania ci sono delle iniziative locali in singoli ospedali. In alcuni casi, inoltre, il programma viene svolto sotto la responsabilità di parti autonome del Paese, come in Italia, Spagna, Germania, Regno Unito, Belgio e Bosnia-Erzegovina.
I LABORATORI E LA COPERTURA
Secondo i dati raccolti nello studio dell’ISNS – al quale ha partecipato anche il prof. Giancarlo la Marca dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer di Firenze – la maggior parte dei Paesi ha solo uno o due laboratori di screening, mentre quelli con una popolazione più numerosa generalmente ne hanno di più (come la Russia che ne ha 78). Non esiste però una relazione evidente tra il numero di laboratori e il numero di nascite, il che porta a carichi di lavoro annuali per laboratorio molto variabili. Negli ultimi anni, a causa dei cambiamenti nella struttura dei programmi di screening neonatale, in Italia e in Francia il numero dei laboratori è notevolmente diminuito, rispettivamente a 15 e 16. La Finlandia nel 2015 ha introdotto lo screening con dried blood spot (campione di sangue essiccato) e ha preso in considerazione l’idea di abbandonare lo screening con prelievo di sangue dal cordone ombelicale, e anche Malta, recentemente, ha deciso di adottare questo metodo. Infine, le più recenti aggiunte ai programmi di screening – atrofia muscolare spinale (SMA) e immunodeficienza combinata grave – sono state realizzate attraverso l’introduzione di tecnologie molecolari.
Nella maggior parte dei Paesi la copertura, definita come la percentuale di neonati inclusi nel programma, è superiore al 90%, e in molti casi è addirittura superiore al 99%, nonostante il fatto che lo screening non sia obbligatorio in alcuno Stato, con l’unica eccezione dell’Italia (dove raggiunge il 96,7%). Le coperture segnalate al 99,9% o al 100%, però, devono essere considerate con cautela: anche con i migliori registri delle nascite e registri di screening neonatale, infatti, un certo numero di neonati idonei non sarà sottoposto al test; inoltre va ricordato che le cifre citate per la copertura includono anche le famiglie che rifiutano l’esame nei Paesi in cui è facoltativo. In Kirghizistan e Turkmenistan la copertura del 30% è dovuta al fatto che i programmi di screening sono iniziati solo di recente.
Per quanto riguarda invece il materiale informativo per i genitori, è oggi disponibile nel 94% degli Stati sotto forma di opuscoli scritti o tramite siti web, e si tratta di un miglioramento significativo rispetto al 66% del 2010. Circa il 64% dei Paesi, prima di eseguire il test, richiede il consenso ai genitori: una percentuale quasi uguale a quella del 2010. Il consenso per la conservazione a lungo termine dei dried blood spot, invece, è richiesto solo nel 30% delle nazioni.
LA LOGISTICA E LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
Quasi tutti gli Stati effettuano lo screening utilizzando il sangue prelevato dal tallone dei neonati. Il tempo consigliato per il prelievo dopo la nascita è variabile: il 13% dei Paesi lo raccomanda dopo 24 ore, il 67% dopo 48 ore, il 18% dopo 72 ore e il 2% in seguito. La media è di 48-72 ore dopo la nascita, molto più tardi rispetto a quanto avviene, ad esempio, negli Stati Uniti. Queste differenze sono dovute principalmente alla diversa organizzazione del programma di screening e dell’assistenza alla maternità: alcuni Paesi eseguono il test in ospedale prima che la madre e il bambino vengano dimessi, mentre in altri, ad esempio nel Regno Unito, il campione viene prelevato dall’ostetrica o dall’assistente sanitario quando sono già tornati a casa.
Diversi Paesi mettono a disposizione dei genitori tutti i risultati dello screening, online (ad esempio attraverso un portale digitale riservato a pazienti e genitori) o via mail. Altri riportano i risultati dello screening esclusivamente agli operatori sanitari, e i genitori vengono informati solo se sono necessari ulteriori accertamenti, come una visita specialistica o un secondo campione.
LE CONDIZIONI SOTTOPOSTE A SCREENING
Storicamente, lo screening per la fenilchetonuria (PKU) è stato il primo ad essere introdotto, negli anni ’60, seguito da quello per l’ipotiroidismo congenito. Intorno al 2005-2010, l’iperplasia surrenalica congenita (CAH) e la fibrosi cistica sono state incluse in diversi Paesi.
Il pannello delle condizioni sottoposte a screening si è poi gradualmente ampliato, con un aumento alla fine degli anni ’90 con l’introduzione della spettrometria di massa tandem in molti laboratori in tutta Europa. L’avvento di questa nuova tecnologia ha reso possibile lo screening di 40-50 patologie (principalmente errori congeniti del metabolismo e in particolare aminoacidopatie, acidemie organiche e difetti dell’ossidazione degli acidi grassi) utilizzando un singolo campione di sangue essiccato.
Oggi, come detto, è l’Italia a guidare la classifica per il pannello più ampio, seguita da Polonia, Islanda, Ungheria, Austria, Slovacchia, Macedonia del Nord e Svezia. Scendendo nei dettagli, dall’analisi dell’ISNS è emerso che tutti i Paesi tranne il Montenegro hanno introdotto la fenilchetonuria, e tutti tranne la Moldavia hanno incluso l’ipotiroidismo congenito. Attualmente, lo screening per fibrosi cistica e iperplasia surrenalica congenita viene eseguito in circa il 50% dei Paesi, quasi il doppio rispetto al 2010. Per le altre condizioni rilevabili dalla spettrometria di massa tandem, lo stato attuale è meno chiaro. La scelta delle patologie da sottoporre a screening dipende spesso dalle conoscenze mediche e tecniche, dall’interesse personale di scienziati, clinici e operatori di sanità pubblica coinvolti nel processo decisionale, e dalla disponibilità di finanziamenti. La scelta, a volte, può anche essere influenzata da gruppi di pazienti che esprimono il proprio sostegno allo screening.
LA COLLABORAZIONE FRA GLI STATI EUROPEI
Una delle principali ragioni per cui è stato possibile compiere questi progressi è lo scambio di conoscenze e l’apprendimento dalle esperienze dei Paesi vicini. Da questo punto di vista l’International Society for Neonatal Screening (ISNS) ha fatto la sua parte: promuove i contatti personali tra i responsabili dei programmi nel corso di conferenze e seminari e sta creando una banca dati disponibile per la consultazione pubblica. Inoltre, ha recentemente stabilito stretti legami con l’Organizzazione internazionale dei pazienti affetti da immunodeficienze primarie (IPOPI), le Reti di riferimento europee per le malattie metaboliche ereditarie (MetabERN) e le malattie endocrine rare (Endo-ERN) e l’Organizzazione europea per le malattie rare (EURORDIS). Infine, l’ISNS, l’IPOPI e la Società europea per le immunodeficienze (ESID) stanno istituendo, nell’ambito della piattaforma della politica sanitaria dell’UE, un progetto che sarà utile a tutte le parti interessate allo screening neonatale, chiamato Screen4Rare.
Resta da vedere se questa collaborazione porterà, ad esempio, alla pubblicazione di un elenco di priorità per lo screening neonatale delle varie condizioni, che tenga conto delle linee guida internazionali, come quelle dell’ISNS, e che aiuti i responsabili politici a prendere le migliori decisioni, o se l’Europa sceglierà un altro percorso. Di sicuro, solo lavorando insieme sarà possibile ottenere il tempestivo rilevamento dei neonati potenzialmente affetti da una delle tante malattie rare, intraprendere le azioni appropriate e migliorare lo stato della salute pubblica per tutti i cittadini europei.