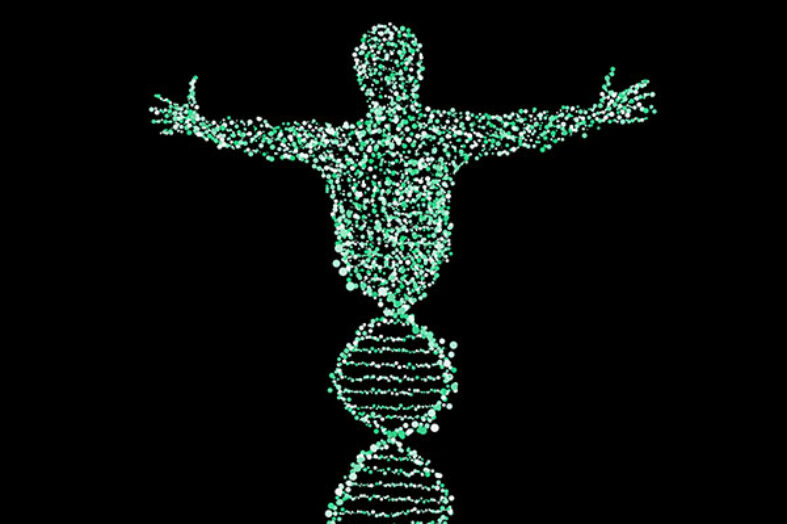Secondo un recente studio internazionale l’analisi genomica fornisce un chiarimento diagnostico nel 31% dei casi. Ma le risorse sono limitate
La maggior parte dei bambini non è affetta dalle malattie ricercate tramite lo screening neonatale, ma nei casi in cui un problema di salute venga effettivamente riscontrato, i benefici di una diagnosi precoce possono essere enormi. Se disponibili, le terapie possono cambiare l’evoluzione clinica della malattia. Recentemente alcuni gruppi di ricerca, stanno realizzando progetti pilota attraverso i quali il pannello di screening “classico” viene affiancato al sequenziamento genomico, per identificare tutti i disturbi genetici nei neonati.
Ad esempio in Italia ad oggi sono attivi il progetto NeoGen, quello di Fondazione Telethon e Ospedale San Raffaele e il progetto Screen4Care, fiori all’occhiello della diagnosi genetica e genomica.
A livello internazionale però si discute molto circa la possibilità di indagare, attraverso lo screening neonatale genetico, la presenza di disturbi del neurosviluppo, con l’idea che una diagnosi precocissima possa ridurre le disabilità ad essi connesse.
Su questo tipo di progettualità di screening sono state avanzate numerose obiezioni a livello internazionale. Prima su tutte la seguente: le terapie oggi a disposizione non sono in grado di soddisfare le esigenze terapeutiche dei bambini con disturbi del neurosviluppo e l’eventuale mutazione predisponente, riscontrata in fase di screening e diagnosi, potrebbe non portare alla malattia. A tal proposito uno studio pubblicato a ottobre 2023 su Pediatrics dalla Prof.ssa Sarah Sobotka del Deparment of Pediatrics dell’Università di Chicago e della Prof.ssa Lainie Friedman Ross dell Department of Health Humanities and Bioethics and Director of the Paul M. Schyve MD Center for Bioethics dell’Università di Rochester propone di sequenziare solo i casi che hanno ricevuto una diagnosi di disturbo dello sviluppo neurologico, così da migliorare le conoscenze genetiche ma senza rischiare disparità nell’assistenza sanitaria. Lo studio si basa sull’esperienza americana, ma è un punto di partenza utile per affrontare il discorso dello screening neonatale e delle possibili applicazioni del sequenziamento del genoma.
DAL TEST DI GUTHRIE AL SEQUENZIAMENTO DEL DNA
Lo screening neonatale identifica, subito dopo la nascita, le condizioni cliniche ancora presintomatiche che possono influire sulla sopravvivenza e sullo stato di salute dei neonati. La diagnosi precoce e l’inizio tempestivo delle terapie possono evitare, attenuare o ritardare la comparsa dei sintomi e prevenire quadri clinici gravi che possono portare a gravi disabilità o al decesso.
In Europa lo screening neonatale è stato avviato negli anni ’60, quando è stato introdotto il test per identificare la fenilchetonuria (PKU) grazie al lavoro del biologo americano Robert Guthrie, da cui prende il nome la procedura che viene fatta ancora oggi. Nel giro di qualche anno si sono aggiunti l’ipotiroidismo congenito e la fibrosi cistica. L’introduzione della spettrometria di massa tandem ha aumentato le possibilità di esaminare più condizioni cliniche contemporaneamente utilizzando gocce di sangue secco raccolte su una tipologia specifica di carta assorbente. I progressi della medicina molecolare hanno contribuito ad ampliare ulteriormente i pannelli di screening, che oggi includono molte malattie metaboliche, alcune immunodeficienze e altre malattie genetiche. In Italia lo screening è stato introdotto nel 1992 – anno in cui divenne obbligatorio per fenilchetonuria, ipotiroidismo congenito e fibrosi cistica – e oggi sono 49 le malattie ricercate nei nuovi nati.
Le malattie incluse nei pannelli di screening neonatale sono quelle per cui è disponibile un test semplice da eseguire e a basso costo, un trattamento efficace, sono ben riconoscibili nello stadio presintomatico o precoce e sono determinate a livello genetico. Se i test evidenziano la presenza di una di queste malattie, vengono fatti ulteriori esami per confermare la diagnosi. L’analisi del DNA, le cui applicazioni sono aumentate negli ultimi anni grazie al progresso tecnico e alle conoscenze scientifiche, è stata usata per la prima volta come test di secondo livello per lo screening per la fibrosi cistica. Oggi ci sono molti sostenitori dell’analisi completa del DNA tramite sequenziamento per la possibilità che offre di identificare tutte le malattie con una componente genetica fin dai primi mesi di vita, ma i costi sono elevati e il rapporto rischio-beneficio non è ancora chiaro. Da qui la proposta di un gruppo di ricercatori, in uno studio del 2022, di concentrarsi solo sui disturbi del neurosviluppo: l’idea è quella di condurre studi pilota per capire se e come queste malattie potrebbero essere identificate efficacemente alla nascita e che impatto potrebbe avere una diagnosi precoce. La difficoltà risiede nel fatto che la causa genetica dei disturbi del neurosviluppo non è sempre ben definita e determinante.
LA GENETICA DEI DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO
L’identificazione di questi disturbi tramite sequenziamento è complessa, perché spesso non c’è un legame diretto tra causa – il gene mutato – ed effetto – la manifestazione clinica – come invece accade ad esempio nel caso della fibrosi cistica o della PKU. La maggior parte dei disturbi del neurosviluppo ha infatti carattere multifattoriale, cioè dipende da più fattori genetici (sono più di 2.500 i geni che sembrano coinvolti) e ambientali che determinano la comparsa della malattia. La genetica può avere un ruolo importante – alcuni rari disturbi sono associati a geni specifici, come il deficit cognitivo non sindromico autosomico recessivo, il deficit cognitivo sindromico non-specificato, la sindrome di Phelan McDermid, e la sindrome da regressione del neurosviluppo, distonia e crisi epilettiche correlata a IRF2BPL (fonte: Telethon) – ed esistono alcuni geni che predispongono maggiormente all’insorgere del disturbo, ma non è detto che si manifesti al 100%, proprio perché devono intervenire altri fattori. Infatti, alcuni bambini identificati come portatori di varianti genetiche ad alto rischio potrebbero non manifestare mai ritardi nello sviluppo o altre disabilità.
Non essendoci una strategia di trattamento specifica per questi disturbi, che possono avere manifestazioni cliniche molto diverse da un caso all’altro, è anche difficile valutare il rapporto tra costo dello screening e i costi associati alla gestione del paziente (uno dei criteri di ammissibilità dello screening neonatale). Le attuali linee guida per i bambini con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, ritardo dello sviluppo o disabilità intellettiva raccomandano un test per identificare eventuali anomalie cromosomiche e un test per l’X fragile nei ragazzi. Come spiegato nello studio, l’analisi dei cromosomi produce un chiarimento diagnostico solo nel 5,7% dei casi di disturbi del neurosviluppo, mentre il sequenziamento del genoma aumenta la resa diagnostica al 31%, e ancora maggiore (53%) se i bambini hanno ulteriori condizioni associate. Ad oggi, però, gli esperti sono ancora divisi su quali test genetici dovrebbero essere eseguiti nei bambini con diagnosi confermata di un disturbo del neurosviluppo e l’approccio si conferma multidisciplinare.
PROPOSTE E OBIEZIONI
Lo studio pubblicato su Pediatrics approfondisce questa tematica e offre argomenti per dimostrare che il sequenziamento del genoma con questo fine rischia di aumentare le disparità a livello sanitario. In primis perché la diagnosi di un disturbo del neurosviluppo richiede competenze cliniche specifiche e la collaborazione di diversi professionisti sanitari e l’analisi genetica non basta o rischia di essere confondente. In secondo luogo, le terapie che sono a disposizione dei pazienti non sono sufficienti a rispondere alle loro esigenze, oltre ad essere complessa e spesso imprevedibile la gestione di sintomatologie e manifestazioni cliniche molto diverse da paziente a paziente.
Un altro parametro evidenziato nello studio è che le attuali conoscenze genetiche potrebbero sbilanciare la diagnostica verso i neonati di ascendenza europea, dato che la maggior parte di studi genomici ha coinvolto pochi partecipanti di ascendenza non europea. Pertanto, il sequenziamento genomico avrebbe il potenziale di esacerbare le disparità di assistenza sanitaria sia nella diagnosi che nel trattamento. Tra le altre problematiche viene sottolineata la carenza di genetisti, medici e terapisti, insufficiente a soddisfare la domanda attuale: nello studio questa affermazione è valida per gli Stati Uniti, che però non è l’unico paese a soffrire di questo problema.
La proposta di includere il sequenziamento del genoma per identificare tutti i disturbi genetici nei neonati può essere valida per alcuni aspetti, ma – secondo lo studio in questione – solleva alcune questioni che restano tuttora aperte.
Se vero è che una terapia precoce attualmente non esiste, è altrettanto vero che sapere per tempo come gestire, ad esempio, le crisi epilettiche o altri sintomi e comportamenti a rischio potrebbe essere utile per evitare gravi conseguenze sulla salute. D’altro canto però aumentare l’identificazione precoce dei soggetti a rischio che potrebbero non manifestare mai ritardi nello sviluppo potrebbe spostare le limitate risorse dei sistemi sanitari verso bambini che non ne hanno realmente bisogno, peggiorando le disparità nell’accesso ai servizi. A questo si aggiunge l’ansia di una diagnosi che non è una diagnosi: etichettare un bambino con una malattia, un disturbo o una sindrome ha un impatto e delle conseguenze sulla sua crescita, sulla gestione famigliare e sulle relazioni sociali e di questo bisogna tenerne conto.
Per evitare che ciò accada, gli autori dello studio suggeriscono quindi di sequenziare solo in seguito alla diagnosi, così da migliorare la conoscenza della componente genetica di queste patologie senza però rischiare di investire le risorse dove non è necessario, di fare diagnosi che non lo sono e di alimentare le disuguaglianze, fin troppo presenti in ambito sanitario. Sequenziare sì, ma non sempre è l’approccio corretto.
Le tecniche di sequenziamento, che negli ultimi vent’anni hanno rivoluzionato la ricerca biomedica, permettono di conoscere la sequenza di un frammento di DNA o dell’intero genoma di un organismo, informazioni fondamentali per diagnosticare e classificare le malattie che sono imputabili a un difetto genetico. Il sequenziamento ha aperto le porte alla terapia personalizzata e potrebbe essere il futuro dello screening neonatale, specialmente se si pensa alle malattie rare e ultra rare. Esistono diversi progetti per valutare l’utilizzo del sequenziamento nella diagnosi neonatale: comprendere a fondo le reali possibilità offerte da questa tecnica è fondamentale per utilizzarla nel modo migliore possibile.